“Versione originale incompiuta” recita la locandina.
Con il suo secondo titolo di stagione il maestro Gianandrea Noseda, alle prese con una importante prise de rôle, dopo aver diretto in ottobre il suo primo Tristan und Isolde, torna sul podio del Regio per un classicissimo dell’opera italiana : quella Turandot che, incompiuta per la morte di Puccini, cerca di guardare al panorama contemporaneo della musica europea e, al tempo stesso, segna la fine dell’opera che suscita grandi trionfi di pubblico.
Scelta che si direbbe quasi obbligata, per il finale del terzo ed ultimo atto : Ricordi, Puccini figlio, Toscanini si attivarono affinché ad un esperto di soggetti esotici, Franco Alfano già autore di Sakùntala, venissero affidati gli abbozzi incompiuti del Maestro, per portare alla fine un compito sulla carta improbo : ciò che non era riuscito a Puccini, passare in un momento dalla morte della dolce schiava Liù alla conversione amorosa della crudele principessa Turandot, poteva riuscire facilmente ad un altro ?
Alfano, pagando un conto salato in termini di unità stilistica e coerenza drammatica, sintetizzò per quanto possibile alcuni temi già esposti e chiuse in gloria la vicenda spargendo a piene mani decibel zuccherosi.
Da subito, le forbici contribuirono a snellire la conclusione ed in occasione del primo ciclo di recite ritagliarono il finale abitualmente eseguito. La sera della prima rappresentazione assoluta, con un colpo di teatro da par suo, Toscanini depose la bacchetta poco dopo la morte di Liù, là dove Puccini si era fermato, lasciando ad altri nelle recite seguenti il compito di proporre il (modesto?) risultato messo insieme.
Complimenti, dunque, alla scelta di Noseda che segue in apparenza la via più originale, nei fatti quella più intelligente : per l’edizione torinese non ricorre al finale di Alfano e neppure a quello, recente, di Berio ma si limita a far terminare l’opera, come alla prima rappresentazione assoluta, con le ultime pagine composte da Puccini. Ironia della sorte, casualità ? proprio il 16 gennaio moriva Arturo Toscanini !
In questo modo, con un finale aperto, la musica si dissolve quasi senza motivo lasciando da parte eccessivi trionfalismi, con il sapore in bocca di un dubbio lieto fine e conquista all’opera una modernità inattesa.
Nei suoi appunti ad un certo punto Puccini richiamò il Tristano, forse alludendo alla trasfigurazione di Isotta sul corpo dell’amato : questa conclusione, tra le versioni possibili, è involontariamente forse quella che più ci trasporta verso il senso di quell’appunto.
La direzione stessa di Noseda, via via che l’opera avanza nell’arco della serata è sempre più coerente con la scelta. Se, infatti, il primo atto è caratterizzato da una lettura ipertrofica che in taluni momenti nuoce alla nitidezza del tessuto orchestrale e mette a dura prove la tenuta dell’insieme, dalla scena degli enigmi in poi colpisce sempre più l’attenzione del direttore nel differenziare i piani sonori e l’andare a ricercare le raffinatezze dell’opera. Per una volta, il racconto della principessa e la scena degli enigmi non sono una raccolta di urla laceranti ma nascono dal cuore di Turandot. I clamori cedono a sonorità smorzate e tempi dilatati.
Un soffio ci accompagna alla conclusione, con Liù che, dopo aver assistito al secondo atto in silenzio è sbalzata al centro dell’attenzione e viene letteralmente inglobata da uno stuolo di principesse Turandot.
È la rappresentazione di un sogno, la proiezione dell’inconscio di Calaf, infatti, l’idea originale da cui prende vita il nuovo allestimento di Turandot, affidato alle cure di Stefano Poda, responsabile di uno spettacolo che conferma quanto di buono la lettura del cartellone faceva sperare.
Per nulla scontata, la visione del regista sfugge all’oleografia da mitica Cina del tempo che fu, cui da sempre si lega la fortuna dell’opera, sviluppando come proiezioni, sogni della mente di Calaf la passione per la crudele principessa.
La vicenda si svolge all’interno di spazi geometrici rigorosi in cui domina quasi esclusivamente un algido bianco, un bianco asettico che assume mille gradazioni per via delle forme squadrate, delle luci decise, dei materiali diversi che compongono la scena.

Nel secondo atto, dietro un’esile quinta sul lato sinistro, a rafforzare il concetto fa la sua comparsa per la scena degli enigmi la chaise longue di Le Corbusier, su cui Calaf attende i quesiti che decideranno della sua fortuna.
Turandot non esiste, ma dalla mente di Calaf sempre più confuso, sul punto di non possederla mai, nascono una, dieci, infinite Turandot tra cui si aggira insensato come Parsifal tra le fanciulle fiore.

A marcare un netto contrasto cromatico, con l’ultimo enigma sarà il rosso fuoco della passione e del sangue ad impadronirsi della scena, mentre, come detto, nel terzo atto la candida Liù finirà per essere letteralmente soffocata da una nuvola nera di principesse Turandot.

Vanamente, all’inizio del terzo atto, Calaf si aggira tra gelide, irte Turandot che non lo degnano di uno sguardo.
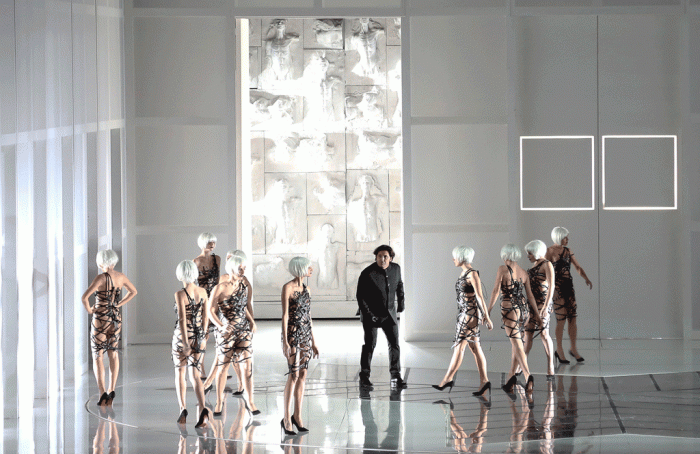
Vero co-protagonista della parte scenica, uno stuolo di ballerini realizza tramite un costante contraltare emozionale grazie a raffinate coreografie che riescono, quasi miracolosamente, a non sviare l’attenzione dalla musica ma, anzi, a rafforzarne l’effetto per mezzo di movimenti raffinati e coerenti che ne amplificano il lato emozionale.
In sintonia con direzione e regia, abbiamo molto apprezzato la Turandot di Rebeka Lokar dalla tecnica sicura in tutta l’estensione vocale, che senza bisogno di forzare eccessivamente restituisce una protagonista lacerata e più umana del solito, inconsciamente rassegnata ad amare il suo Calaf sin dal primo momento.
Buona anche la prova di Erika Grimaldi, artista di casa, che con voce lirica tratteggia una Liù minuta ma non rinunciataria, dal bel colore vocale e dall’ottima recitazione.
Note meno positive dal reparto maschile. Carenze tecniche nell’impostazione della voce costringono Jorge de León ad un Calaf avaro di sfumature, vocalmente monotono ad onta di una bella presenza scenica cui non corrisponde, tuttavia, altrettanta linea musicale. È il registro acuto a soffrirne di più, quando la voce perde l’appoggio e non sfoga.
Poco convincenti anche Ping, Pang e Pong interpretati dai volenterosi Marco Filippo Romano, Luca Casalin e Mikeldi Atxalandabaso, con fraseggio per lo più generico e qualche problema di precisione dell’assieme.
Di rilievo l’ottimo mandarino interpretato da Roberto Abbondanza e corretti gli altri comprimari, come pure il Coro del Teatro Regio che, pur privato dell’apoteosi finale, è stato all’altezza delle migliori aspettative.
Al termine della recita applausi convinti del pubblico all’indirizzo di tutti gli interpreti vocali, del regista e, soprattutto, di Gianandrea Noseda.
