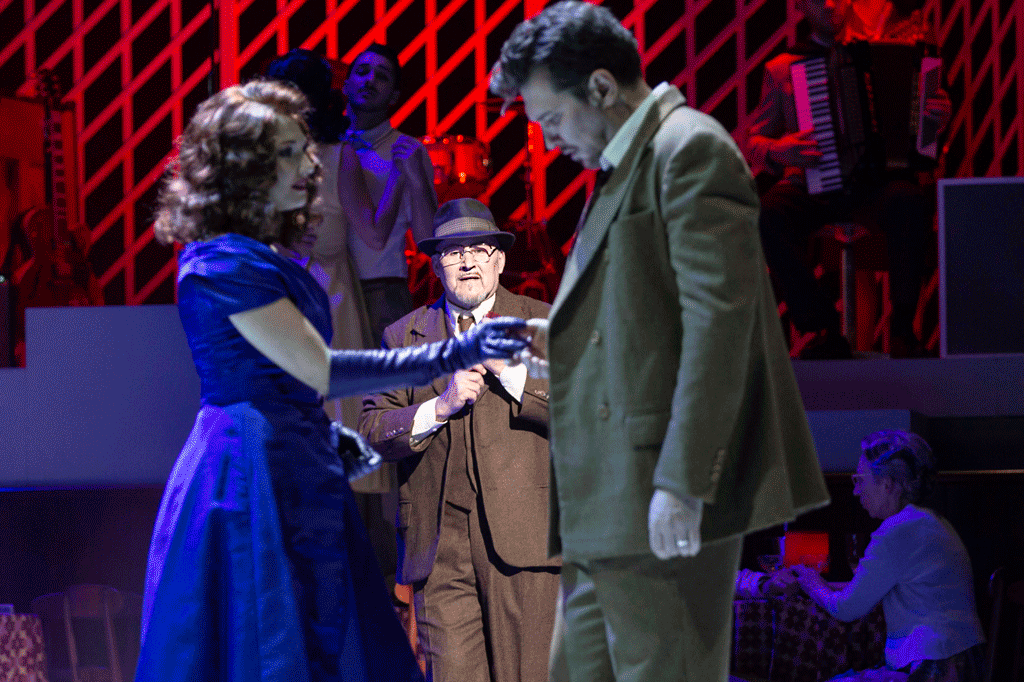Carino è carino, lo spettacolo. Anche se non cattura come dovrebbe. A Roma, il Teatro dell’Opera ha allestito Die lustige Witwe (La vedova allegra) di Franz Lehár (1870–1948) su testo originale in tedesco, in una produzione condivisa con La Fenice di Venezia, dov’era andata in scena lo scorso anno. Nel libretto, la vicenda ha luogo nell’ambasciata parigina del fantomatico regno del Pontevedro. Regno che naviga in cattive acque. L’ambasciatore, il barone Mirko Zeta, ha indetto una festa finalizzata a individuare un candidato pontevedrino che corteggi e sposi la connazionale Hanna Glawari, ricchissima vedova, alla quale il defunto marito ha lasciato un patrimonio immenso. Ciò perché, se per caso la vedova sposasse invece un forestiero, ed esportasse all’estero tale patrimonio, lo staterello pontevedrino rischierebbe il collasso finanziario. La trama procede nel mondo scintillante e fastoso della Belle Époque, tra varie schermaglie amorose, innamoramenti leciti e non, valzer e altre danze, champagne, il famoso locale Chez Maxim’s. Ovvio, dopo molte ansie, il lieto fine che salverà il bilancio del Pontevedro.

L’allestimento è centrato sulla regia di Damiano Michieletto, artefice di progetti creativi e imprevedibili. Stavolta, invece, l’artista veneziano non propone un progetto temerario, sorprendendo chi da lui si aspettava una messa in scena trasgressiva. Con Eleonora Gravagnola regista collaboratore, e con la sua équipe abituale – Paolo Fantin per le scene, Carla Teti che firma i bei costumi, Alessandro Carletti per il disegno luci, Chiara Vecchi per i movimenti coreografici – Michieletto ha ideato un’ambientazione che, gravitando l’argomento attorno al danaro, anziché in ambasciata è collocata nella Pontevedro Bank. Il barone Zeta ne diviene il direttore, e tutto il resto di conseguenza, cominciando dal coprotagonista Dànilo che non appare più come conte, bensì come svogliato passacarte. In una scenografia anni cinquanta, un po’ squallidotta agli occhi nostri com’è ovvio, la regia disegna vivaci movimenti collettivi, che si alternano alle danze. Alquanto spoglia, sempre in linea con la collocazione a metà Novecento, è anche la scena del secondo atto. Anziché lo sfarzo di ricchi divani, lampadari e tendaggi di casa Glawari, c’è il malinconico salone di una balera, con desolanti tavolini e sedie addossati alle pareti. E i balli in partitura sono giustamente risolti a passo di rock ’n’ roll, twist e simili. Teneramente poetico, però, è il momento del ballo di due anziani, lento e solitario. La scena del terzo atto ? Anziché il mitico ristorante Maxim’s – nella realtà da molti anni, con la sua meravigliosa boiserie in stile art nouveau, in capo alla maison Pierre Cardin – ecco l’anonimo ufficio di Dànilo, che, reduce da una sbornia, si addormenta allo scrivania, e sogna la festosa irruzione delle scatenate grisettes, e del loro can can. Insomma, un progetto visivo nell’insieme coerente, innovativo, molto ben realizzato e senza particolari choc. E allora, perché alla fine della prima (ma non alle repliche), insieme ai moltissimi applausi sono piovuti dei buu all’indirizzo di Michieletto e del suo team ? Perché la parte di pubblico più conservatrice e benpensante ha contestato, si può presumere, l’assenza di lustrini, sontuosità, e pompe in stile Belle Époque. Ma una messa in scena come quella di trent’anni fa, memorabile, di Mauro Bolognini sempre all’Opera, non so se reggerebbe all’evoluzione odierna del gusto. Comunque, i pochi cavernicoli che al Teatro dell’Opera hanno buato questa Vedova allegra lo fanno perché rifiutano a priori il genio di Damiano Michieletto, come si è visto da spettacoli precedenti.
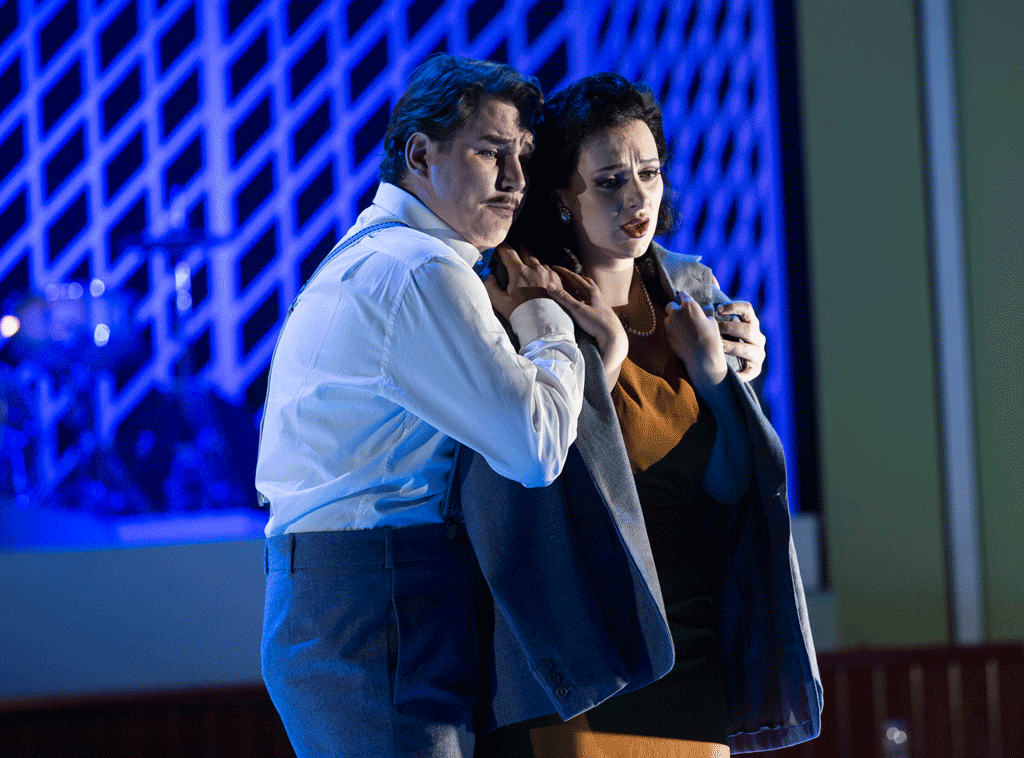
Certo, qualche perplessità è legittima, soprattutto perché quest’edizione non riesce divertente e coinvolgente come si vorrebbe. Ma la risposta si trova nella direzione d’orchestra di Constantin Trinks, pur attenta e sobria. Fin troppo, vien da dire. Elegante, sì, nel soppesare equilibri, colori, finezze della partitura, e anche nel canonico rallentando sul secondo quarto del tempo di valzer. Però gli stacchi sono troppo lenti, secondo una sensibilità un tantino âgée e perfettina, che sa di perbenismo mitteleuropeo. E questa è una lacuna che pesa sull’intera esecuzione ; il primo atto, in certi momenti, è addirittura soporifero. Di sicuro non ci sono le bollicine e l’effervescenza che ci aspetteremmo. Peccato : un direttore tecnicamente bravo, ma di gusto compassato. Di orchestra e coro, quest’ultimo preparato da Roberto Gabbiani, non si può che dire benissimo : si sono tutti visibilmente divertiti. Quanto alla compagnia di canto, irreprensibili le due protagoniste femminili, i soprani Nadja Mchantaf (Hanna Glawari) e Adriana Ferfecka (Valencienne). Vocalmente impeccabili, e anche disinvolte nel movimento. E pazienza se non posseggono quell’appeal, vocale e personale, che solo sa creare seduzione. Meglio il versante maschile, anche sotto quest’aspetto. Il baritono Paulo Szot è un Dànilo divertente, di bella e brillante vocalità, bravo nel riuscire sfaticato e cialtroncello col suo abito tabacco stazzonato, da impiegato qualunque. Perfetto il barone Zeta impersonato da Anthony Michaels-Moore, sciolto e spiritoso. Da parte sua, il tenore Peter Sonn dà bel rilievo, vocale e interpretativo, alla figura di Camille de Rossillon, mentre raffinata ed efficace appare la dimensione che Michieletto ritaglia per il cancelliere Njegus, ruolo che non ha parti vocali, ed è sempre affidato a un attore, qui Karl-Heinz Macek, che risolve molto bene. Eliminati vari passi recitati, in questa regia Njegus parla poco. Però diventa il deus ex-machina dell’ingranaggio narrativo, da lui comandato con il ventaglio brandito a mo’ di bacchetta magica, e polvere di stelle profusa in quantità. Un’idea delicata e funzionale. Ben assortito il resto del cast : nelle seconde parti i tenori Marcello Nardis, St. Brioche, e Simon Schorr, Cascada, con il baritono Roberto Maietta, Kromow. Poi tutti attinti dal Progetto “Fabbrica” del Teatro dell’Opera i bravi comprimari : il baritono Timofei Baranov, Bogdanowitsch, il mezzosoprano Rafaela Albuquerque, Sylviane, il soprano Irida Dragoti, Olga, il baritono Andrii Ganchuk, Pritschitsch, il soprano Sara Rocchi, Praskowia.