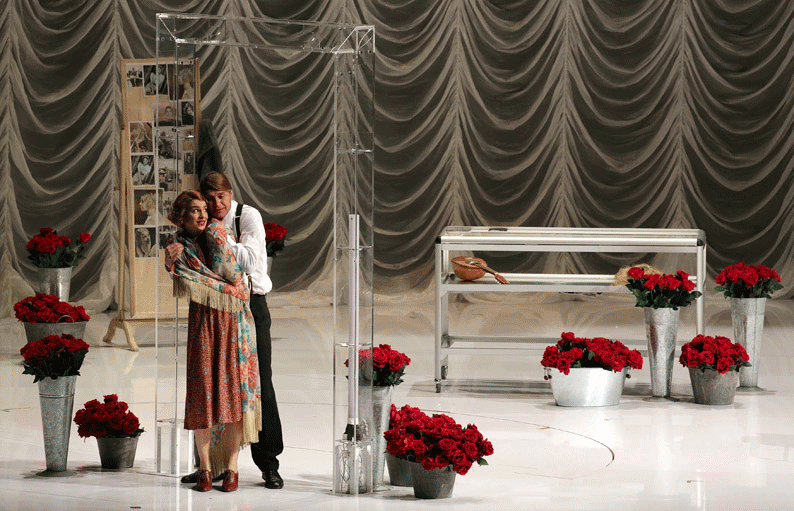
La scoperta di Die Tote Stadt, cui è invitato il pubblico della Scala, è inseparabile dalla conoscenza del suo autore Erich Wolfgang Korngold, uno dei più geniali del Novecento, ma non dei più eseguiti in Italia. Ecco perché il teatro ha colto l’occasione di questa nuova messinscena per far precedere ogni recita (dal 28 maggio al 17 giugno) da una conferenza introduttiva del musicologo Franco Pulcini, esperto del repertorio novecentesco. E da un convegno guidato da altri illustri musicologi, aperto al pubblico il giorno della prima, dedicato a un approfondimento dell’opera.

Premesse che non mancano d’interessare e di far crescere l’attesa per uno spettacolo sicuramente fuori dall’ordinario, grazie anche a un cast d’interpreti d’alta classe. Sul podio c’è Alan Gilbert, già direttore musicale di prestigiose orchestre quali la Filarmonica di New York e applaudito alla Scala nel 2017 per il Gershwin di Porgy and Bess.

La regia è di Graham Vick, uno dei talenti più originali e contesi della messinscena musicale dei nostri giorni, che anche alla Scala ha realizzato lavori eccellenti tra cui un memorabile Macbeth diretto da Riccardo Muti. Ben scelti sono i cantanti, dal tenore Klaus Florian Vogt, celebre wagneriano ma non solo, a un giovane soprano entrata nel rango delle star qual è Asmik Grigorian, al baritono Markus Werba fedelissimo e amatissimo alla Scala. Tutti si dichiarano affascinati da quest’opera, a cominciare dal regista che afferma : “Non la conoscevo e, in un primo momento, mi ha impaurito per il suo eccesso di ricchezza tematica che si presta a diverse e contrastanti chiavi di lettura. Poi me ne sono innamorato in crescendo, come avviene per i capolavori”.
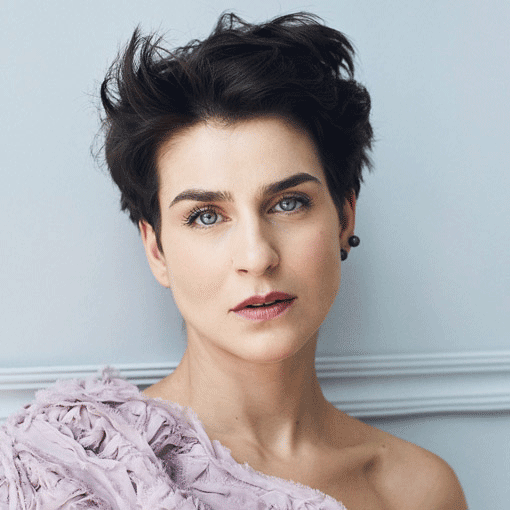
Si tratta infatti di una vicenda sospesa tra realtà e visioni oniriche, protagonista un uomo che vive nella spettrale città di Bruges e che coltiva morbosamente il ricordo dell’amata moglie defunta. Fino a quando incontra un’altra donna che le somiglia come una goccia d’acqua e che sconvolge nel profondo i suoi sentimenti e il suo agire. Con un colpo di scena mozzafiato Korngold capovolge il finale drammatico del romanzo che ha ispirato il libretto e scioglie il suo intreccio misterioso e conturbante, riportando nella vita reale i personaggi. “Personaggi molto complessi da interpretare anche dal punto di vista vocale”, nota Klaus Florian Vogt, che veste i panni del protagonista e che non esita a definire questo ruolo, per lui non nuovo, tra i più difficili e insieme più interessanti della sua carriera. “Canto e recitazione coincidono e fanno di Die tote Stadt un passaggio fondamentale della modernità musicale”. Parere condiviso dal direttore Alan Gilbert, il quale sottolinea : “E’ un’opera che, pur accogliendo le più significative influenze dell’epoca di composizione, da quelle post-wagneriane e pucciniane a quelle delle prime avanguardie novecentesche, è profondamente originale. Un autentico pezzo unico, che riflette l’unicità del suo autore”.
Carattere che infatti si ritrova nella vicenda artistica di Korngold, nato nel 1897 a Brno in Austria, cresciuto in una famiglia della borghesia ebraica all’ombra del padre influente critico musicale, enfant prodige allievo di Zemlinsky e ammirato fin dalle sue precoci produzioni da Richard Strauss e da Gustav Mahler. Messosi in luce a soli diciannove anni per due atti unici, Violanta e Der Ring des Polycrates sotto la direzione di Bruno Walter, giunse ventitreenne al successo con Die tote Stadt dopo il debutto a Colonia con Otto Klemperer sul podio. L’opera, ispirata al romanzo simbolista Bruges-la-morte di Georges Rodenbach e tradotta in libretto da Paul Schott, pseudonimo di Zemlinsky padre, raccolse anche il plauso di Puccini e lanciò il giovane autore in tutta Europa. Ma nel 1934 Korngold si trasferisce in America, al riparo dalle leggi razziali delle dittature europee. Qui costruisce una seconda brillante carriera nel cinema, diventando uno dei maghi delle colonne sonore di Hollywood. Senza tuttavia abbandonare le composizioni classiche, come il Concerto per violino dedicato ad Alma Mahler ed eseguito per la prima volta da Jascha Heifetz. Ma quelle composizioni, bandite in Europa, rimasero fuori repertorio sino alla fine del Novecento. E Korngold, morto a Los Angeles nel 1957, non potè assistere alla loro riscoperta, di cui questo debutto alla Scala del suo capolavoro segna un momento importante.
