
Andiamo con ordine : nel primo atto l’impressione è decisamente positiva : il Mandarino di Armando Gabba è efficace, sferzante, asciutto e risoluto come il suo ruolo e la scrittura di Puccini richiedono. L’orchestra si destreggia con eleganza anche nei brutali urti che rammentano Stravinsky e di cui si ricorderà sin troppo bene Orff. La scenografia è minimale ed elegante ; i numeri degli atti, nella prima edizione della partitura, sono contenuti in graziose cornicette liberty ; regista e scenografa (Cecilia Ligorio e Alessia Colosso) si appropriano di tale decorazione, la ingigantiscono e le fanno racchiudere l’intero proscenio, creando un efficace distacco dalla realtà ; Turandot è infatti una fiaba crudele e priva di magia, con tutte le caratteristiche di questo genere ancestrale. L’immaginazione deve correre sulla realizzazione di una delle partiture più variopinte e del genio lucchese ; la scena è eloquentemente spoglia, – scolpita dall’intelligente luminotecnica curata da Fabio Barettin – e ospita pochi, ricercati elementi : una piattaforma lineare scende dalla torre scenica e si arresta a mezz’aria ; imperiosa vi incede Turandot spargendo petali. Quindi sorge una glaciale falce di luna, acuminata lama che precipita al momento dell’esecuzione del principe di Persia. Riusciti i costumi di Simone Valsecchi, disinvolti tra la lussureggiante verità fiabesca dei protagonisti, l’astrazione atemporale delle maschere e delle masse e l’attualità borghese del Mandarino.
Il trio Calaf-Timur e Liù è espressivo ed efficace : la schiava interpretata da Carmela Remigio è una donna risoluta anche nella sua condizione servile, che agisce per sincera devozione mantenendo una propria volontà, lettura coerente con lo sviluppo successivo del personaggio e rispecchiata nella vocalità decisa e piena del soprano. Simon Lim è un Timur dalla perfetta voce tartarea, cavernosa e sonante ; Calaf, inizialmente convincente nella concitazione, si rivela presto chiassoso ; ma si tratta di rabbia e sfida, potrebbe essere una screziatura ricercata dall'interprete : Walter Fraccaro. L’impressione s’incrina quando, abbagliato alla vista della principessa, si produce in un canto languido e affettato da portamenti più vicini a veri e propri glissandi ; ma riuscirà a superarsi.

Un plauso al trio Ping, Pong e Pang (rispettivamente Alessio Arduini, Paolo Antognetti e Valentino Buzza), affiatati ed equilibrati, vocalmente convincenti e a loro completo agio in scena, dotati come sono di una verve ironica per nulla scontata.
Nel complesso, tutto risulta convincente e a tratti addirittura entusiasmante sino alla metà del secondo atto, quando fa il suo ingresso Turandot non più per mostrarsi alla folla ma – ahinoi – per cantare. Sin dalle prime sillabe si è colpiti dallo stridore di un timbro piatto e glaciale, privo di regalità ma anche di qualsiasi rotondità di armonici, tutto spigoli e linee spezzate, povero di inflessioni e, come se non bastasse, dotato di uno spiccato accento dell’Est Europa.

Cercando distrazione nel libretto di sala, notiamo che si tratta di Oksana Dyka, autentica diva più attenta a primeggiare sul palcoscenico che a coltivare voce e dizione. Costei infatti, oltre a vessare il nutrito pubblico veneziano per tutto il resto dell’opera, commette anche uno sgarbo fulminando con lo sguardo la brava Remigio, colpevole di aver suscitato un’ovazione.

Gossip da melomani, se si vuole, che però conferma il fatto che nel suo ruolo, la Dyka, ci crede poco o nulla. Lo stesso non si può dire, appunto, per Carmela Remigio, che interpreta una morte di Liù di tale intensità e commozione che il teatro si produce in un fragoroso quanto meritato applauso.
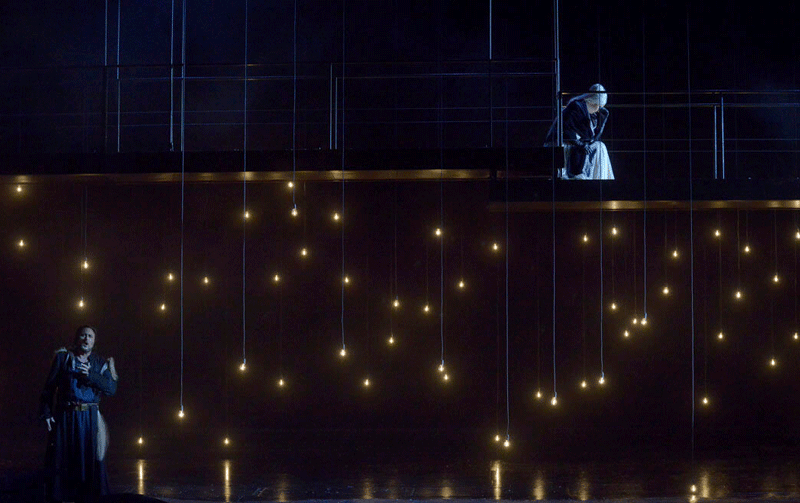
L’apice della volgarità, tuttavia, lo tocca Fraccaro all’inizio del terzo atto, con un Nessun dorma di rara melensaggine e dalla dizione imperdonabilmente sciatta : consonanti inesistenti o trascurate, tutto un ululare tra vocali esageratamente aperte, ove le I e le U non esistono e trasmutano in É e Ó. Callegari ha il buon gusto di non concedere nulla agli inevitabili applausi scroscianti (che fortunatamente non ottengono il tradizionale bis) e continua come non si trattasse di uno dei più celebri e abusati brani operistici di sempre. Bravo, maestro.
Una delle sciagure della cultura (in qualsiasi sua manifestazione) si annida nel divismo, che – lungi dall’essere estinto – è riuscito a rendere spiacevole una Turandot altrimenti raffinata e ricercata, con tutte le carte in regola per essere ricordata come un'ottima produzione.

