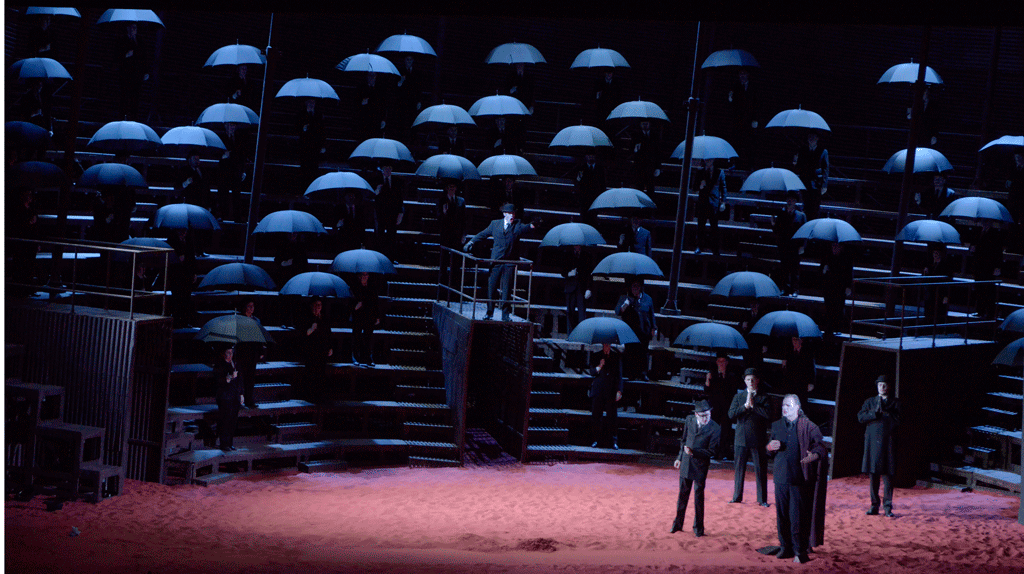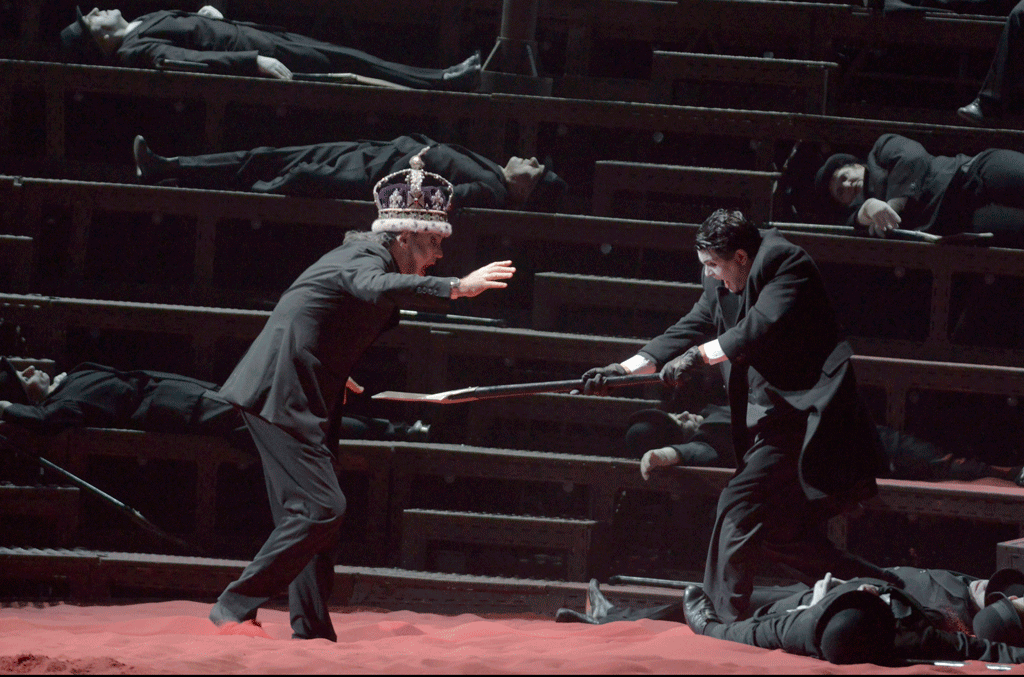
Sin dai primi secondi l’orchestra rivela una scrittura fitta, densa, ricca di dettagli e colori. Tito Ceccherini regge il podio con maestria : padroneggia la complessa partitura e convince tanto nei poderosi brani d’insieme, quanto nei minuti dettagli strumentali, che il compositore inserisce in abbondanza per lumeggiare e caratterizzare taluni momenti del dramma. Cupa inquietudine, brutalità ancestrale, forza vitale primigenia promanano dalla simbolica caccia al verro che apre l’opera (ripresa nel finale quando Richard viene paragonato a un bloody and usurpant boar). Un’orchestra colossale capace di sonorità estreme : dal barrito dilacerato della tuba al fischio disperato dell’ottavino, ogni àmbito sonoro è presente ed esplorato dal lavoro di cesello di Giorgio Battistelli. Il coro è doppio : una sezione sul palcoscenico e una seconda dietro le quinte a creare, con numerosi interventi, scenografie sonore efficacissime, fantasmi, ossessioni. Al coro sono infatti affidate le solennità rituali in corrispondenza di ogni evento drammatico, con interventi su testi latini scritti in “stile osservato”.

Colpisce la corrispondenza tra palcoscenico e buca : lo spettacolo è totale e ogni gesto musicale si manifesta quasi inevitabilmente in un gesto teatrale coerente, mimetico o simbolico. Un esempio : all’ingresso di Richard nel consesso dei nobili, gli strappi degli ottoni e degli archi corrispondono alla veemente irruzione del futuro re, al suo canto franto e studiatamente greve, alla sua gestualità scomposta, rudely stamped, in una corrispondenza cinematografica. Delude, da questo punto di vista, la decisiva battaglia finale, brano riuscitissimo e di intensità sovrumana in cui orchestra e coro danno vita a un autentico combattimento in cui nessun colpo viene risparmiato. Le movenze sul palcoscenico non possono riprodurre una musica tanto tremenda : è necessario ricorrere a una gestualità simbolica, che però risulta spenta, fioca, stanca, visivamente poco efficace.

La regia di Robert Carsen è accuratissima, scarna, brutale ; quasi trasposizione teatrale di una pellicola di Wiene o Murnau, colloca il dramma all’interno di un’arena sghemba e arrugginita, ideale chiusura a cerchio dell’elegante sala all’italiana, squarciata affinché ci si possa sentire al suo interno. Un po’ stadio fascista all’abbandono e un po’ teatro anatomico dismesso, il coro di personaggi spersonalizzati e vestiti alla Charlot ne sfrutta la gradinata praticabile e vi si muove con meccanica secchezza. Colori pressoché assenti ; i pochi sono violenti : l’onnipresente, ossessiva, impalpabile sabbia rossa – efficacissimo sangue da palcoscenico – che cattura magneticamente e proietta nella spirale drammatica del protagonista ; i giocattoli infantili che vi vengono gettati, terribili nella loro quotidiana semplicità come le voci bianche dei principini – per la verità quasi inudibili ; le fragole, sanguinario rituale eucaristico per i seguaci di Glouchester che ne assumono la gibbosità.
Difficile valutare vocalmente un’opera simile : al protagonista è richiesta una prova estremamente fisica, una presenza costante in scena, una gestualità tesa e scattosa, una mimica grim-visaged che non concede un solo istante di distensione. La voce di Gidon Saks si rivela spaventosamente adatta al compito, come del resto la sua persona dinoccolata e sbilenca, perfettamente inserita nell’ambiente creato dalla scenografia, come la sua maschera facciale grottesca, autentico villain.
 Una certa uniformità del linguaggio rende l’ascolto a tratti ostico, specialmente nella scrittura vocale : l’opera si dipana in un accompagnato pressoché continuo, in alcuni momenti prevedibile nella sua melopea dai ritmi ricorrenti, ancorché perfettamente modellata sulla versificazione inglese.
Una certa uniformità del linguaggio rende l’ascolto a tratti ostico, specialmente nella scrittura vocale : l’opera si dipana in un accompagnato pressoché continuo, in alcuni momenti prevedibile nella sua melopea dai ritmi ricorrenti, ancorché perfettamente modellata sulla versificazione inglese.
Suscita inizialmente perplessità la linearità drammaturgica del libretto, soprattutto nel corso del primo atto. Gli eventi politici e i fatti di sangue si svolgono senza un apparente sottotesto, che non sia la brama irrazionale di potere ; momenti in cui il dramma rivela prospettive più ampie e mette dolorosamente di fronte alla lacerazione interiore giungono però con il secondo atto in presenza dei due principali personaggi femminili. È durante i dialoghi con la madre e con la moglie, infatti, che la vicenda guadagna spessore introspettivo e costringe a riflettere sulla cupidigia cieca e folle e sull’irresistibile fascino che esercita.
La tirata conclusiva di Henry VII risulta sbrigativa e didascalica, quasi di troppo sullo sfondo sonoro di un coro che, nella citazione di un lamento rinascimentale, supera sé stesso. Nel finale Battistelli ricorre allo stile antico per creare una sonorità ancora mai udita e diradare così le plumbee nebbie del discontent che gravano su tutta l’opera. Una trasfigurazione di cui la musica si rivela non di rado capace. Più del libretto, essa stessa è dramma.