Un incontro con Gianni Forte, della compagnia ricci/forte.
100% Furioso
Abbiamo pubblicato in francese un'intervista a Gianni Forte svolta a Perpignan, dove la Compagnia è in residenza per tre anni (al teatro l'Archipel), in occasione dello spettacolo su Pier Paolo Pasolini (PPP) Ultimo inventario prima di liquidazione.
Siccome ci vengono evocate molte problematiche del teatro di ricci/forte, abbiamo pensato opportuno proporla in italiano, in occasione del Nabucco presentato al Festival Verdi di Parma a partire del 29 settembre prossimo. Pensiamo che per il futuro spettatore di questa produzione, sarà una bella "preparazione".
_________
Enfants terribles del teatro italiano, Stefano Ricci e Gianni Forte hanno fondato nel 2006 il ricci/forte Performing Arts Ensemble.
Si sono formati presso Luca Ronconi a Roma e Edward Albee alla New York University, e hanno sviluppato un linguaggio teatrale verso “spettacoli-performances” dove il corpo dell’attore occupa uno spazio determinante. Aprendo una via di mezzo tra Jan Fabre e Romeo Castellucci, si collocano al crocevia tra danza, teatro e arte contemporanea in una forma di rivendicazione che trova il suo asso portante nella denuncia del consumismo, l’invasione delle immagini e i danni fatti dalle mitologie contemporanee.
Aldilà di una violenza metafisica, troviamo negli spettacoli di ricci/forte la permanenza di un pensiero che colloca poesia e corpo al centro dell’interesse, come rivelatore e mezzo per sottolineare le fragilità e debolezze umane.Ricci/Forte sono per ora artisti associati presso il Théâtre de l’Archipel a Perpignan ((nel sud della Francia, capitale della Catalogna francese)). In occasione della ripresa di PPP, ultimo inventario prima di liquidazione, omaggio a Pier Paolo Pasolini, abbiamo voluto presentare il loro lavoro e le prospettive che apre in un mondo e in un’Europa dove suona come un grido di disperazione.
“ricci/forte”, è come un marchio comerciale?
Più esattamente, siamo un duetto, un po’ come i cowboys dei western di Sergio Leone negli anni Settanta, back to back, uno essendo il censore dell’altro. Quando un’artista è solo, è assediato dal dubbio; in due, i dubbi si sciolgono, perché i punti di vista si declinano al plurale. Meglio non fidarsi di certezze monolitiche, non fermarsi al compiacimento. E poi, ogni gioia non condivisa muore sul momento. Infatti, alla radice della parola dubbio, c’è la parola duo, cioè l’oscillazione tra almeno due possibilità. Riflettiamo sempre in due, nulla va lasciato al caso. Siamo davvero due schizofrenici, due intransigenti clandestini, due corpi estranei in perpetua migrazione, fuggendo sempre quella prigione repressiva, cioè tutto quello che è ordine stabilito nel quale siamo e boia e vittima. Solo quando riusciamo a strappare questo fondale sottile delle nostre esistenze e a scoprire tutto quello che si nasconde dietro, potremo alzare il sipario sull’anima di una nuova epoca, e coltiveremo finalmente la nostra libertà di uomini nuovi.
Producete in due?
Più esattamente, siamo un duetto, un po’ come i cowboys dei western di Sergio Leone negli anni Settanta, back to back, uno essendo il censore dell’altro. Quando un’artista è solo, è assediato dal dubbio; in due, i dubbi si sciolgono, perché i punti di vista si declinano al plurale. Meglio non fidarsi di certezze monolitiche, non fermarsi al compiacimento. E poi, ogni gioia non condivisa muore sul momento. Infatti, alla radice della parola dubbio, c’è la parola duo, cioè l’oscillazione tra almeno due possibilità. Riflettiamo sempre in due, nulla va lasciato al caso. Siamo davvero due schizofrenici, due intransigenti clandestini, due corpi estranei in perpetua migrazione, fuggendo sempre quella prigione repressiva, cioè tutto quello che è ordine stabilito nel quale siamo e boia e vittima. Solo quando riusciamo a strappare questo fondale sottile delle nostre esistenze e a scoprire tutto quello che si nasconde dietro, potremo alzare il sipario sull’anima di una nuova epoca, e coltiveremo finalmente la nostra libertà di uomini nuovi.
Producete in due?
Lavoriamo insieme per la scrittura drammaturgica. Per quanto riguarda la messa in scena, è firmata da Stefano. Sono come il grillo parlante di Pinocchio sulla sua spalla, che esprime costantemente il suo parere, chiacchiero sempre ma in modo sincero e spassionato. Sono il suo angelo custode. E lui, il mio.
Come vi siete incontrati?
Abbiamo iniziato come attori. Eravamo cosiddetti due rivali, due giovani attori sempre impiegati per lo stesso tipo di ruoli. Abbiamo lavorato in compagnie famose, con registi come Mario Missiroli, Luigi Squarzina, Roberto Guicciardini ... Siamo stati molto apprezzati sulla scena italiana ma non ci eravamo mai parlati. Ci siamo davvero incontrati a Palermo, facevamo parte di due compagnie diverse che venivano a recitare al Teatro Biondo. Una sera sono andato a vedere Stefano recitare e l'ho trovato eccezionale. Alla fine dello spettacolo, sono andato nel suo camerino per congratularmi con lui. Avevo le mie cose con me in uno zaino ed ero così sconvolto che l’ho dimenticato nel camerino. All'interno, c'era il manoscritto di un'opera teatrale che stavo scrivendo. Il giorno successivo, Stefano rimandò il mio manoscritto in hotel e, aprendolo, scoprii che aveva continuato a scrivere la commedia. Ero sbalordito. Ho pensato: "È fantastico, è il mio mondo, era quello che volevo scrivere! ". L'ho chiamato e abbiamo parlato tutto il giorno. Abbiamo immediatamente capito di avere la stessa visione artistica, lo stesso mondo onirico e visionario. Abbiamo detto: "Cosa stiamo facendo? Continuiamo, ma insieme? ". Abbiamo deciso di iniziare la nostra collaborazione come autori prima di creare la nostra compagnia nel 2006. Abbiamo scoperto che l'ordine alfabetico dei nomi forte / ricci non suonava bene, quindi abbiamo optato per ricci / forte!
Avete seguito l’insegnamento di Luca Ronconi?
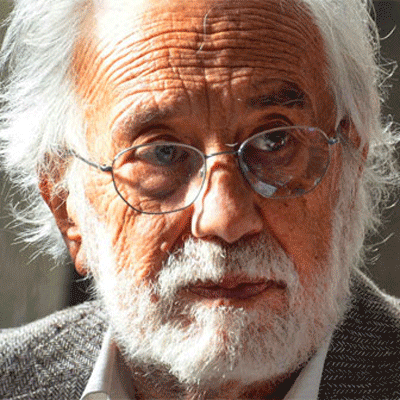
In quel periodo Luca era il grande maestro dell'Accademia Nazionale d’Arte Drammatica "Silvio D'Amico". Aveva un suo modo di analizzare il testo, meticolosamente e in profondità, come uno speleologo. Poteva rimanere su un verso, una frase, una riga per settimane e settimane. Tagliava il testo parola per parola. Questo modo di lavorare ci ha colpito molto ed è per questo che, all'inizio, abbiamo deciso di mettere il testo al centro dei nostri processi creativi. Le nostre prime opere teatrali erano classiche, nel senso che erano composte da atti e personaggi. Poi siamo andati negli Stati Uniti e lì abbiamo scoperto il performing art, la realtà di un hic et nunc, per essere sé stessi, in tempo reale sul palco senza giocare o fingere di interpretare un personaggio. Da allora, la nostra scrittura è cambiata perché noi, Stefano e Gianni, siamo cambiati. Gradualmente, abbiamo iniziato a usare improvvisazioni e attori -performers. I nostri spettacoli sono come noi: sono puzzle, puzzle in cui ogni pezzo trova finalmente il suo posto giusto. Diciamo la vita così com'è, senza ordine, perché in realtà non esiste nessun ordine. La frammentazione, la non linearità danno un ritmo sincopato allo spettacolo e ne accentuano il dramma. Il nostro teatro è una zona franca dove tutto è possibile, come nel laboratorio dell'alchimista, è il luogo dove si possono mostrare cose che il pubblico di solito non vede. Abbiamo già gli occhi per guardare il mondo, sul set dobbiamo mostrare qualcos'altro, qualcosa di inedito.
Insegnate anche?
Ci piace condurre Master class e trasmettere la nostra esperienza ad altri. Diamo loro con immenso piacere tutti gli strumenti a nostra disposizione. L’immaginario ricci/forte è molto imitato, clonato, sia dagli studenti che dagli ex-attori che hanno recitato nella nostra compagnia: carriere turbo o attori emergenti pirotecnici che si bruciano le ali dal secondo lavoro, come i bagagli su ruote made in China. Preferiamo l'effetto granello di sabbia che possa rallentare l’ingranaggio. Ricordiamoci che a un certo punto devi sapere come uccidere il padre. Abbiamo fatto anche questa "liquidazione" del padre con Luca Ronconi.
Come si sa, una delle sue produzioni più famose è l'Orlando Furioso dell'Ariosto. Abbiamo riscritto il pezzo a Mosca, grazie all'invito perspicace di Kirill Serebrennikov e del Teatro Gogol e poi del NET Festival. Era ovviamente un corpus creativo lontano da quello di Luca Ronconi. L'abbiamo poi recensito e gli abbiamo mostrato estratti dal nostro 100% Furioso (2013/14). Per Luca, è stato un tributo ideale. Era felice, molto orgoglioso e ci ha invitato al Piccolo Teatro di Milano...

Perché abbandonare il testo?
L'innesco è stato Troia’ discount (2006), uno spettacolo che presenta il canto IX dell'Eneide, gli atti eroici di Euryale e Nisus, due interruttori da un sobborgo di oggi. È stata l'ultima delle nostre opere scritte interamente prima dell'inizio delle prove, sempre con personaggi, ma in cui abbiamo iniziato a introdurre il lavoro sul corpo. Abbiamo inserito un coach fisico che si è unito alla compagnia. Dopo il nostro viaggio negli Stati Uniti, abbiamo capito che le parole non erano l'unica cosa importante. Il corpo poteva parlare, e a volte più forte e più intensamente del discorso. Gli attori sono diventati performers, funzioni essenziali della drammaturgia. Abbiamo eliminato una certa continuità narrativa e rotto l'idea diacronica della temporalità della narrazione, attraverso una simultaneità di azioni e talvolta anche con la mobilità del pubblico nello spazio. Non è una gratuita violazione di regole e tradizioni, ma una complementarietà, per permettere allo spettatore di ricomporre la propria visione attiva dello spettacolo. Dopo lo Troia’ discount, i dialoghi cominciarono a scomparire, dando luogo a suite di monologhi, flussi di coscienza. Il nostro teatro evoca la scomparsa del dialogo tra le persone. È come nella vita reale, non ci parliamo più, siamo sempre soli davanti ai nostri schermi. Comunichiamo con il mondo intero, ma nella realtà con nessuno. È terrificante! Noi soffriamo, amiamo, facciamo l'amore...dura una frazione di secondo e ci distendiamo da soli, con centinaia di selfies a testimoniare che siamo lì. Oggi, siamo in un periodo di anemia emotiva.

Questo uso della performance si riferisce alla politica?
I critici hanno scritto che siamo stati i pronipoti di Pasolini. Siamo diventati più impegnati politicamente. Abbiamo detto ad alta voce il nostro disgusto per la società contemporanea, il nostro disgusto per i supermercati e le cattedrali consumistiche della borghesia. Il teatro è politico. E la nostra intenzione è di poetizzare la politica (come la rivolta politico-poetica di André Breton e dei surrealisti), di essere creativi nel cacciare gli oppositori di lunga data, come fece il subcomandante Marcos quando attaccò un campo militare con aerei di carta. Il nostro spettacolo è dunque un atto d'amore e di rispetto per la memoria di Pier Paolo Pasolini e delle migliaia di altri che, come lui, sono anonimi, dimenticati, torturati, massacrati e uccisi con violenza.
Qual è l'origine di questo linguaggio teatrale, molto brutale e molto violento?
Siamo il risultato di ciò che viviamo, di ciò che leggiamo anche noi. Sentiamo in noi l'eco dei maestri che hanno vissuto prima, senza che siano per forza i nostri ispiratori. Quello che vediamo non è mai qualcosa di nuovo, ma piuttosto qualcosa che abbiamo già dimenticato. Solo lo sguardo è nuovo. Il teatro è un materiale vivo, ancor più del cinema o delle arti visive, e ci permette di vedere più chiaramente attraverso il vetro nebbioso del presente. Il nostro abbraccio orfico con linguaggio poetico può sembrare brutale a prima vista, ma ci permette di evitare di diventare meccanismi di riproduzione di parole preconfezionate, al servizio di tutti coloro che vogliono disattivare, nel nostro cervello, la fondamentale facoltà di critica.
L'immagine è al centro del vostro lavoro, e ci occupa un posto ossessivo. È un paradosso quando si pensa che questo sia un uso molto cattolico e molto blasfemo.
Come la maggior parte degli italiani, abbiamo ricevuto un'educazione cattolica. È impossibile misurarne assolutamente le conseguenze, ma possiamo dire che le nostre creazioni sono in un certo senso creazioni "cristologiche". C'è una connessione molto forte, è come un attentato di immagini davanti al pubblico. Questo è anche il significato del teatro. All'inizio, alcuni sono venuti allo spettacolo e hanno protestato. Non siamo alla ricerca di scandalo, ma d'altra parte, non ci piace spettatori seduti lì, comodamente sulla loro poltrona di velluto rosso, come farebbero sul loro divano. A ricci/forte, lo spettatore è una persona unica, attiva, attenta e che deve partecipare alla creazione dello spettacolo con tutti noi. È un momento di scambio che non si ripete mai nello stesso modo. Quando lascia la sala, vogliamo che porti con sé qualcosa che è entrato sotto la sua pelle, nel suo sistema venoso. Vogliamo che continui a pensare a ciò che ha visto, che si ponga domande e che il dubbio scuota le sue certezze.
Scrivete qualche volta cose in diretta interazione col pubblico?
Sì, si chiamano performance site-specific, in cui il performer è in contatto diretto con lo spettatore. Può essere fatto in un bagno, garage, camera d'albergo o cucina di un ristorante. Il pubblico è vicino o intorno ai performers, a volte a pochi centimetri di distanza. Le persone possono toccarli, sentire il loro sudore e guardarli negli occhi. In cambio, il performer sente anche il battito cardiaco del pubblico e questa presenza diretta che lo circonda.
Il teatro è puro o impuro?
Nella vita cerchiamo la purezza senza sapere se la raggiungeremo con precisione. È un'utopia. D'altra parte, il teatro rimane un luogo puro dove si può ancora aggrapparsi alle viti della curiosità; è il paradiso dell'immaginazione, un antidoto alla nostra solitudine, l'unico luogo al mondo in cui vale la pena di vivere: se ci si allontana dai limiti della fantasia, si diventa più poveri e la notte diventa un nero volgare e insopportabile.
E questo titolo: "Ultimo inventario prima di liquidazione"?
In Italia, quando un negozio chiude, c'è un cartello: ultimo inventario prima di liquidazione. Con Stefano, ci siamo chiesti: cos'è l'artista oggi? Ci poniamo la domanda a noi stessi. Perché continui a fare questo lavoro? Certamente, lavoriamo ovunque, viaggiamo, siamo fortunati. Ma a volte è molto difficile trovare un significato a ciò che si sta facendo. Che cos'è un artista? Uno stronzo? Un santo? Un idiota? Una società che uccide i suoi poeti è una società malata. Il nostro ultimo spettacolo, EASY TO REMEMBER, è dedicato a Marina Tsvetayeva, una poetessa russa vittima dello stalinismo. La società non ama il poeta perché la fa pensare e si rifiuta di farlo. Pensare, ragionare fa molto paura. Tanto vale nascondere tutto sotto la sabbia, tuffare la testa nella sabbia. I poeti pongono domande a una società che di solito pensa solo a fare soldi tutto il tempo. Io sono perché ho guadagnato, e sono ciò che guadagno. Guadagno, quindi sono…altrimenti non sono niente. La rispettabilità economica è legata alla questione del potere. In un tale contesto, la cultura è molto pesante e onerosa per i nostri governi, non è redditizia. Non resta che gettarla nella spazzatura. La liquidazione è un inventario che si prende con la propria vita. Pier Paolo Pasolini fu ucciso perché disturbava persone, sia politiche che culturali, e scuoteva della società dell'epoca. La nostra non si è evoluta molto e Pasolini è più vivo che mai, tra noi. Il suo pensiero, il suo lavoro è qualcosa di molto attuale perché è premonitore. Ci parla di ciò che può ancora accadere e in modo ancora più serio di allora.

Il consumo è il nuovo fascismo?
Assolutamente si. È una sete, una concupiscenza, in cui viviamo e, allo stesso tempo, l'indifferenza verso l'oggetto ambito. Una bulimia che permea la nostra società: tutto, subito, ma soprattutto per me. Siamo in una civiltà intrappolata nella fossa comune del lamento istituzionalizzato, in balia della globalizzazione, del despotismo del mercato di massa, del consumismo e della banalizzazione culturale. Faccio un esempio: la mattina, durante le tournée, faccio colazione con gli attori. Ascolto il modo in cui parlano dei programmi televisivi. La serie è diventata il loro piccolo e coccolone giocattolo. Rimani a casa da solo, prepari la cena e accendi il computer per guardare i tuoi amici di fantasia, vivere con loro. Stiamo aspettando il prossimo episodio come la nascita di nostro figlio. Nel 2009, il nostro show Macadamia Nut Brittle ha già parlato di questo, della dipendenza della gente dagli show televisivi. È esattamente quello contro cui combattiamo e perché facciamo teatro. La poesia permette di prendere le distanze dalla banalità della vita, per restituirle un significato profondo. Non è una fotografia, ma una visione d’autore della società. Dovrebbe essere l'unica cosa indispensabile che ti fa viaggiare con gli occhi spalancati, come l'aria che respiri. Il pubblico non è come una mandria di pecore condotte al macello. Quest'idea fa schifo.

C'è nostalgia nei vostri spettacoli?
Non c'è nostalgia in senso stretto, ma testimonianze legate alla purezza dell'infanzia e dell'adolescenza, come tappe di una vita molto performativa e alla costante ricerca di un'identità. "Vedere le cose con il cuore", come dice la volpe al Piccolo Principe.

Cosa rappresentano queste variazioni di colore di sfondo in PPP?

In questo spettacolo ci riferiamo principalmente all'ultimo periodo di Pasolini, quello di Salò e Pétrole, il suo periodo più disincantato. Non volevamo fare un pezzo biografico. Abbiamo giocato con queste variazioni cromatiche sullo sfondo della scena. Sono i colori delle opere di Jacopo da Pontormo, pittore che Pasolini amava molto. È il dipinto La Deposizione di Cristo che appare in La ricotta, terzo sketch del film collettivo RoGoPaG. Questi colori sono aciduli, molto vivaci. Il giallo è il colore del deserto, un luogo che Pasolini amava particolarmente e che si ritrova in molte delle sue produzioni cinematografiche. Il rosso è il sangue, la vita che scorre sotto la nostra pelle. Il verde, le foreste di Emilio Salgari, l'autore di Sandokan e delle sue storie esotiche. Il blu è il colore del mare - un mare che è anche la madre e il fluido amniotico in cui si ritorna alla fine.
Recentemente, voi siete passati dalla tragedia all'opera lirica. Perché questa scelta dell'opera?
La musica è sempre stata presente nel nostro lavoro. Due anni fa abbiamo avuto un'intervista con un giornalista che ci ha chiesto cosa volevamo fare in futuro. Abbiamo subito risposto: "L’opera! - E quale opera? - La Turandot di Giacomo Puccini", venne spontaneamente. Qualche giorno dopo abbiamo ricevuto una telefonata da Francesco Micheli, direttore del Macerata Opera Festival di Macerata. È così che è iniziata l'avventura. Con la nostra prima opera lirica, abbiamo vinto il premio "Franco Abbiati" come migliore regia dell'anno 2017. Questa stagione, abbiamo messo in scena Die glückliche Hand di Schönberg e Il Castello di Barbablù di Bartók al Teatro Massimo di Palermo. Ripetiamo questo dittico la prossima stagione al Teatro Comunale di Bologna e, a settembre, una nuova produzione: il Nabucco di Verdi al Teatro Regio di Parma.

Ma non si può lavorare nella lirica come nella prosa?
Per Turandot, abbiamo avuto la fortuna di avere ottimi cantanti disponibili come attori teatrali. Abbiamo lavorato sodo insieme, hanno dovuto imparare ad esibirsi sul palco con movimenti complessi e fianco a fianco con gli esecutori dell'ensemble ricci/forte. Abbiamo imparato molto da questa esperienza. Ci siamo trovati di fronte ai limiti della scena lirica e abbiamo trovato modi originali per superare gli ostacoli. Non abbiamo toccato il libretto, tranne una piccola cosa che ha fatto scorrere molto inchiostro, perché nella nostra versione, Liù è morta uccisa dalla mano di Turandot.

Altri progetti?
Metteremo in scena I Racconti di Hoffmann di Offenbach alla La Fenice di Venezia, e a Bergamo, un’opera poco conosciuta di Donizetti: Marino Faliero. Inoltre, attualmente e per tre anni, siamo artisti associati all'Archipel, la scena nazionale di Perpignan. Questa struttura ci aiuta a co-produrre e presentare il nostro lavoro al pubblico francese. Abbiamo anche un progetto in fase di sviluppo con RAI 3.
La situazione in Italia è al momento molto delicata. Lei ha conosciuto il periodo Berlusconi e ora è il ritorno della Lega con Salvini...
(Intervista svolta nel maggio 2019, quindi prima del cambio di governo)
All'inizio, infatti, è stato molto difficile, a causa di Berlusconi e della sua disastrosa politica culturale. Nel 2005, quando abbiamo fondato la compagnia, nessuno ha creduto in noi. Prima di allora, avevamo lavorato a lungo come sceneggiatori per la RAI e, grazie ai soldi che abbiamo guadagnato con la televisione, siamo stati in grado di produrre i nostri primi programmi. Il pubblico ha immediatamente invaso le sale. Il passaparola ha funzionato e le critiche sono seguite.
Oggi la situazione sta peggiorando: è sempre più difficile per il teatro, con Salvini alle manette e i suoi drastici tagli al budget della cultura. Un clima più deleterio che mai ha afflitto l'Italia. Fortunatamente, il nostro ensemble è ancora molto in giro per il mondo. Siamo invitati ovunque, e presto a San Pietroburgo, poi di nuovo in Spagna e in Brasile. Per noi due anime in transito, sempre altrove, il futuro non è necessariamente solo in Italia.
© Rosellina Garbo (Il Castello di Barbablù)
© Amedeo Carpentieri (Troia's Discount)
© Alfredo Tabocchini (Turandot)
© Chiara Saitta (Easy to remember)
© François Stemmer (Darling, Ipotesa per un'Orestea)
© Daniele e Virgina Antonelli (Macadamia Nut Brittle)
